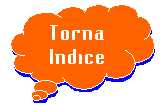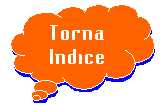
BRONZINI
INTRODUZIONE
a
Fiabe Pugliesi
Regionalità
storica delle fiabe pugliesi
|
La fisionomia regionale delle fiabe pugliesi, in assenza di
una tradizione narrativa propria di questa regione, è una incognita che si può
risolvere in positivo o in negativo, quantomeno intravedere, soltanto dopo aver
effettuato una serie di comparazioni e prospezioni del materiale (e non solo di
quello, quantitativamente ridotto, compreso nella presente silloge).
Il
comparativista ha davanti a sé due strade: l'una che congiunge fra loro i
prodotti delle diverse letterature regionali di tradizione orale circolanti
nell'ambito di un'area storica determinata (pur toccando punti di diffusione
esterni a quest'area in una dimensione geografica o culturale che va molto al di
là della regione e della nazione, ma che è opportuno esaminare per gradi);
l'altra che tende a individuare il rapporto dialettico nella stessa area storica
(dove ne manchino i referenti nella singola regione, com'è per la nostra) fra i
diversi livelli di creazione e ambiti di fruizione di un medesimo genere di
narrativa popolare. Le due strade
s'intersecano e vanno pertanto percorse simultaneamente. Imbocchiamo la seconda,
che può aiutarci a dare una direzione più esatta anche alla prima e forse può
aprire nuove prospettive di analisi congiunta di materia, forma e ideologia,
osservando però i processi dal basso e sostituendo come parametro critico al
diagramma consueto di popolare e aulico quello socio-culturale dei diversi
codici narrativi di rappresentazione del popolare.
A
parte il dialetto, che va considerato sul piano della potenzialità e resa
espressiva e riguarda pertanto prevalentemente il giudizio estetico, se si
confronta una fiaba pugliese (pugliese nel senso fruitivo che abbiamo detto) o
abruzzese, calabrese, siciliana ecc. con la fiaba o le fiabe del Basile che
svolgono lo stesso tema o un tema diverso con uguali motivi novellistici,
constatiamo che la letterarietà dello stile dello scrittore napoletano
racchiude una popolarità folclorica e ideologica più impegnata a rappresentare
la realtà
che
è sottesa alla fiaba e che si costituisce come anti-fiaba, per usare una felice
definizione di A. Jolles. Quella
del Basile, vista nel quadro della cultura meridionale, non è una mera
elaborazione artistica di materia narrativa popolare e orale fine a se stessa,
è una operazione intellettuale che, sotto il manto di una raffinatissima forma
letteraria, dà legittimità letteraria e veicolazione dotta agli elementi più
profondi e contestativi della struttura e concezione del mondo subalterno,
opponendoli a quelli della struttura e concezione del mondo borghese: una
opposizione che la fiaba popolare di tradizione orale non è riuscita mai ad
esprimere in proprio per la sua estraneità al circuito della cultura ufficiale.
In tale prospettiva la fiaba popolare pugliese o quella d'altra provincia
dell'antico reame di Napoli si pone formalmente in antitesi ma sostanzialmente
in accordo con la fiaba letteraria.
Prendiamo,
ad esempio, una fiaba complessa, quella che nella presente antologia s'intitola Due
figli di pescatore a palazzo reale, il cui testo dialettale è in La Sorsa
III, n. XXII, pp. 99-105, coi titolo Du'
figghie de pescatàure devéndene rré.
Essa è composta di due storie, corrispondenti ai tipi 300 (The
Tivins or Blood Brothers, 'I due fratelli') e 303
(The Dragon-Slayer, 'L'ammazzadraghi') dell'indice Aarne-Thompson. Questa
forma composita risulta diffusissima in Europa, dove pure risultano diffuse
indipendentemente le due fiabe, come ha dimostrato il Ranke (1931 e 1934). La
fusione sarebbe avvenuta in Francia non più tardi del sec. XIV, ma il racconto
della uccisione del drago ha il suo più antico nucleo nel mito classico di
Perseo e Andromeda. Tuttavia questo
rapporto col mito, che pare evidente, costituisce la preistoria del racconto,
mentre la sua storia ha inizio con la formalizzazione novellistica
dell'originale o degli originali da cui sono derivate le versioni dell'Europa
medievale e moderna (cfr. Thompson
[1946] 1967, pp. 45.58). In Italia si conoscono molte versioni, congiunte e
disgiunte, delle due fiabe: ce ne danno atto le raccolte e le classificazioni
regionali. La versione pugliese tiene tanto delle versioni toscane quanto delle
versioni calabresi, siciliane e abruzzesi.
Più
o meno equidistanti dal polo toscano e da quello siciliano risultano essere
altre fiabe, in cui si riscontra solo una minima prevalenza di corrispondenze più
frequenti e marcate con le versioni meridionali. Il che induce a trasferire la
classifica di meridionalità sul piano funzionale, mentre conferma la grande
mobilità, preminentemente orale, della materia novellistica. Tale mobilità è,
però, anch'essa almeno
in parte storicizzabile, sia nel passaggio dalla forma orale a quella scritta e
viceversa, sia negli scambi culturali che si sono avuti tra paesi, stati e
regioni. Anche nel repertorio
pugliese di novellistica orale si rispecchiano fasi e momenti di un tale
movimento esterno e interno: quello esterno fu particolarmente intenso ed esteso
con gli stati centro-settentrionali della penisola italiana in età aragonese,
che fu senza dubbio l'epoca più produttiva e fruitiva di tale materia. Esso
coinvolse politicamente e culturalmente nel suo insieme tutto il reame di
Napoli, ma si sviluppò in particolar modo per ragioni commerciali in qualche
singola provincia o regione: la Puglia fu particolarmente interessata alle
relazioni marittime con Venezia e con i centri orientali del mercato europeo
cinquecentesco. Il movimento interno è costituito dalla circolazione
interregionale di racconti popolari e letterari, favorita da scambi e ricambi di
varia natura che si sono avuti in età medievale e moderna, alcuni dei quali
sono continuati fino ad oggi: veicoli di trasmissione di cultura orale narrativa
sono tanto i pastori che migrano dall'Abruzzo in Puglia e viceversa seguendo il
ciclo di una transumanza annuale che si ripete ininterrottamente dall'antichità,
quanto i contastorie siciliani che ancora occupano qua e là qualche
piazza di paese pugliese, come Canosa: essi, è vero, recitano in versi più che
raccontare in prosa (non mi risultano in Puglia cantastorie ambulanti), ma
taluni racconti popolari dipendono direttamente da canti narrativi appartenenti
al repertorio dei cantastorie di professione. Il Mezzogiorno adriatico (Abruzzo
e Puglia) va, dunque, ricongiunto ai due massimi poli del triangolo storico
della cultura meridionale (Sicilia e Napoli), i cui lati andrebbero percorsi
interamente attraverso le regioni intermedie.
Che
la Sicilia sia stata per la narrativa popolare di tradizione orale un potente
centro di irradiazione è incontestabile; ma non si può escludere che
altrettanto fertile sia stato l'ambiente napoletano, dove la trasformazione o
rielaborazione letteraria fu più immediata e continuativa, sì da rendere
possibile in alcuni casi una popolarizzazione di ritorno della materia orale,
una volta assunta nella sfera aulica, come sembra essere avvenuto per la fiaba
delle Tre melarance, che dovunque
(anche in Puglia). segue lo schema fissato nel Pentamerone (cfr. Thompson
[19461 1967, p. 144). Il che, però,
è avvenuto di rado, ché nella maggioranza dei casi in regioni di periferia,
come in Puglia, la materia narrativa orale rimase estranea a quella elevazione
di tono e di significati che si ebbe a Napoli attorno alla corte, per adulazione
o satira. Ci è pressoché ignoto,
perché allora non rilevato
e scarsamente
raccolto dopo, il repertorio novellistico napoletano di tradizione orale a cui
certamente attinse Basile, le cui novelle sono - come dice il Thompson ([1946]
1967, p. 260) - «o vere e proprie fiabe orali o fiabe di origine letteraria, ma
già assorbite dal folclore italiano», fiabe, comunque, «che, spesso, fanno la
loro prima apparizione letteraria proprio in queste raccolte [di Straparola e di
Basile]». Epperò tutto lascia supporre che il repertorio novellistico
napoletano non fosse molto diverso da quello siciliano, calabrese, pugliese,
abruzzese, che ci è stato trasmesso oralmente e che è stato dall'800 in poi
raccolto dai demologi, nonché rielaborato da scrittori d'ispirazione popolare
che non mancano anche in Puglia (anche se una ricerca volta a individuare i
collegamenti tra tradizione scritta e orale, che pur s'intravedono soprattutto
nell'Ottocento salentino, è ancora da tentare).
Rispetto
al repertorio noto dell'area meridionale - e qui teniamo presente per
l'occasione quello pugliese, ma altrettanto eloquente sarebbe quello abruzzese o
calabrese, per non dire del siciliano, di più salda costituzione e maggiore
autonomia -, la originalità del Pentamerone
non consiste solo nella forma, che è letterarizzata al massimo e infusa di
magnifico barocco (e anzi per questo non si tratta tanto di originalità quanto
di novità professionale e culturale dell’autore), ma nella tendenza propria
dei letterati del Cinquecento europeo di ricondurre la materia novellistica al
suo originario potenziale di rappresentazione, tragica o comica, reale o
figurale, dritta o rovesciata, dei più elementari e
vitali bisogni umani della carne e dello spirito, alternando nello stile il
basso al sublime e facendo affiorare o esplodere l'elemento corporeo e
carnevalesco in modo più eccentrico e dirompente, tale da superare le barriere
dimesse e stagnanti della novellistica di solo uso e consumo popolare. In questa
prospettiva mi pare calzante vedere, come fa Calvino, nell'arte di Basile la
manodopera di un 'deforme Shakespeare.', ma altrettanto se non più appropriato
è forse riconoscere nell'autore del Pentamerone sotto la maschera giocosa il volto serio,
bachtinianamente scopribile, di un Rabelais.
Ché quello di Rabelais nei confronti con la cultura popolare non fu un
caso isolato, bensì un costume letterario diffuso e, ancor più, un progetto
intellettuale di vaste proporzioni, volto a immettere l'elemento fiabesco in
letteratura e a farne un'arma dal dolce taglio contro il sistema borghese e i
suoi tabù.
Proprio
la novella dei Due figli del mercante, che
occupa il trattenimento VII della prima giornata del Pentamerone,
confrontata
con il suddetto racconto pugliese di Due
figli di pescatore a palazzo reale (v. p. 51 della presente raccolta) e con
le corrispondenti versioni delle regioni meridionali, ci offre alcune
significative prove di un tale salto e stacco formale della narrazione. La quale
ne acquista in spessore ideologico con le similitudini popolaresche e le
metafore scolaresche nel loro stridere al contatto con le formule barocche di
stile salottiero: con forza non posseduta dalla maniera popolare di raccontare 'storie',
come queste, se non più di queste, quelle similitudini e metafore scolaresche
sono consustanziali alla ideologia popolare dell'autore.
L'elemento corporeo e carnevalesco affiora, infatti, soprattutto in
alcuni intermezzi in cui si dà la stura al mondo della crapula e del sesso,
come nell'addio a Napoli di Cienzo che riecheggia e quasi ripete in qualche
passo l'addio del Carnevale morente al suo esercito culinario nei tradiziona1i
contrasti con la Quaresima: “Addio, pastinache e foglie molli; addio, zéppole
e migliacci; addio, cavoli e tarantello; addio, caionze e centofigliuole; addio,
piccatigli e ingrantinati!” (cito dalla traduzione di B. Croce). E non mancano
immagini di matrice carnevalesca che, meglio di quelle d'uso letterario e
poetico, valgono a precisare sensazioni individuali e collettive, come si
evidenzia nel finale di questa sequenza: «E, mentre così dicevano, ecco, dal
fondo di una cavernaccia, uscire il dragone: oh mamma mia, com'era brutto! Fa'
conto che il sole si rimpiattò per paura dentro le nuvole, il cielo s'intorbidò
e il cuore di tutta quella gente si mummificò; e tale fu il tremito che non le
si sarebbe potuto infilare per clistere nemmeno un pelo di porco».
Questo scenario è una delle invenzioni del Basile che hanno profonde
radici nella cultura popolare tradizionale ed è coerente col motivo
dell'allontanamento di Cienzo: l'accidente capitatogli durante una sassaiuola di
aver fracassato la testa del figlio del re di Napoli. Questo motivo ha pure una
sua specifica storicità, data dalla situazione politica reale del rapporto tra
monarchia e popolo, che esso intende mettere in piazza con un episodio di zuffa
tra ragazzi.
Un
altro esempio vistoso si ha nella Cerva fatata del
Pentamerone, dove l'evento
magico del parto viene così dilatato alle cose: «[... ] di lì a pochi giorni,
figliarono; e la trabacca del letto fece un lettuccio, il forziere uno
scrignetto, le sedie sedioline, la tavola un tavolino, e il cantero un
canterello verniciato così bello ch’era una delizia». Una tale lievitazione
carnevalesca è sconosciuta alla fiaba popolare, che si limita nella versione
pugliese (come in quella siciliana) a riportare il suggerimento e il vaticinio
del pesce al pescatore e il suo avverarsi, eseguito che fu il suggerimento del
pesce, con lo stile e il tono di un fatto reale e naturale: «”Ora puoi
uccidermi. Solo ti raccomando di
piantare le mie due pinne in un campo e di serbare in due bottigliette il mio
sangue. Dopo un anno vedrai che tua moglie partorirà due bambini, la giumenta
due puledri e la cagna due cagnolini.” Il pescatore eseguì quanto gli veniva
suggerito e allo scadere di un anno si avverò tutto quello che gli era stato
predetto ». La differenza è notevole e consiste in ciò. Mentre il narratore
popolare lascia o fa rientrare l'elemento magico e straordinario nella
dimensione del reale e del normale, Basile fa straripare l'elemento magico e
straordinario rimarcando la duplice dimensione reale e irreale, ma dando nello
stesso tempo all’irreale una connotazione fortemente realistica con motivi,
tratti, immagini e espressioni del grottesco fisiologico, che ottiene risalto
per contrasto dall'uso sapientissimo di uno splendido linguaggio barocco.
Insomma il Basile conferisce ai due racconti dei Figli
del mercante e della Cerva fatata, oltre
che un colorito stilistico nuovo, uno spessore ideologico di matrice popolare
che la corrispondente fiaba congiunta di circolazione orale nelle stesse regioni
meridionali non riesce a esprimere. Questa, come si nota nella versione
pugliese, conforme alla tradizione europea, fa accordare senza nodi forzati il
tema dell'ammazzadraghi a quello dei due fratelli.
La
via del comparativismo verticale fra la base popolare e il suo apice letterario,
nel rivelarci un rapporto fra le due fasi non di palese opposizione ma di
profonda relazione, in cui la differenza è data (contrariamente a quanto si
crede) dal maggior carico di effervescenza folclorica che la creazione o
elaborazione dotta riesce a riversare nel testo narrativo, porta a rivedere
l'opinione corrente sul fronte demologico, che assegna un maggior grado di
contestatività al prodotto popolare. La
satira, per sua natura, è tanto più forte quanto più è coperta dal manto
della letteratura; così pure taluni nessi simbolici di antico e vitale
significato etnologico, come quello di sesso-prosperità-defecazione, che
costituiscono il perno del moto rivoluzionarlo della cultura carnevalesca,
vengono messi allo scoperto dal sapientissimo gioco delle metafore attraverso
una ridondanza di epiteti, sinonimi e accrescitivi in serie.
Un
così dilatato universo folclorico ideologicamente finalizzato e letterariamente
espresso con un irrompente flutto verbale manca o meglio è sommerso nella
favolistica popolare da cui quella letteraria si è sviluppata con un altro
linguaggio e per un diverso pubblico: il linguaggio della cultura ufficiale e il
mezzo della scrittura offrono al narratore, in questi casi di parallelismo
funzionalmente differenziato, ben maggiori possibilità di rendere
folcloricamente il messaggio di idee e concezioni opposte a quelle della cultura
ufficiale. C'è da dire anche che il pubblico della corte è più idoneo dello
stesso pubblico della piazza a percepire il messaggio nella sua forma
iperfolclorica.
Il
linguaggio del narratore popolare ha, però, dalla sua parte potenzialmente due
elementi che lo caratterizzano nei periodi di effettiva funzionalità sociale e
culturale dell'attività narrativa a livello popolare. Uno è costituito
dall'aderenza al canone del mito come coscienza e regola narrativa, sin dalla
formula iniziale del “c'era una volta”, finché questa mantiene la sua
pregnanza mitica di fatto vero avvenuto una volta e ripetibile tutte le volte
che si racconta. Oggi, al contrario, il “c'era una volta” viene ripetuto dal
narratore e suona a chi ascolta come il primo segnale d'irrealtà di ciò che
sta per essere narrato. Né il termine 'storia' con cui viene denominato ogni
racconto può dirsi che tradisca l'ascendente delle 'storie' medievali narranti
imprese e vite di eroi e di santi, credute vere.
Ché anzi 'storia' indica proprio un racconto non vero e di poco conto.
L'altro elemento caratterizzante l'oralità del narrare popolare è il
gesto, il cui apporto espressivo compensa l'assenza di materia verbale.
Entrambi, canone mitico e modo gestuale, colti in condizioni ottimali d'impiego,
che sono quelle di sintonia funzionale, concorrono a ripetere il fatto al
momento in cui viene raccontato e rendono superflua la descrizione verbale.
Da qui la secchezza e laconicità del linguaggio narrativo orale, che non
vanno attribuite a, povertà espressiva ma al senso di concretezza e di aderenza
al vissuto individuale del narratore popolare, anche se, pur così generalmente
caratterizzato, il suo linguaggio si differenzia da area ad area e da regione a
regione ed è ovviamente più scarno là dove, come in Puglia, manca una
tradizione narrativa aulica di materia popolare che abbia potuto o possa tener
viva dialetticamente quella delle classi subalterne, che oggi potrebbe trovare
forse solo nella funzione letteraria la sua ragione di vita.
Tra
i fatti stilistici e linguistici nei racconti pugliesi e in gran parte comuni
alla novellistica meridionale di tradizione orale sono: la prevalenza del
discorso diretto e il predominio della costruzione paratattica; l'uso ridotto di
sostantivi astratti e la personifìcazione di essenze spirituali, come
“anima”, che ha il significato di persona; scarso impiego di aggettivo
qualificativi, alcuni dei quali sono polivalenti, come “forte”, che spesso
sta per ricco o potente (nu forte tesoru,
n'omu forte), dove si noterà come l'estensibilità dell'idea di forza a
quella di ricchezza e potenza segue un paradigma ideologico tipico delle classi
subalterne meridionali; la forma del superlativo con l'aggettivo ripetuto (puerieddi puerieddi, 'poverelli poverelli', asatte asatte “esatto
esatto”); fitto impiego di dimostrativi; quanto ai verbi e alle forme verbali
si notano le stesse caratteristiche del linguaggio popolare d'uso quotidiano,
con prevalente uso del presente, che assume il valore di futuro con l'avverbio
di tempo (tu mo crai passi, 'domani
passi'). Se ne può dedurre che il
linguaggio dei narratori popolari pugliesi e meridionali in genere non solo è
lontanissimo dal linguaggio dei narratori letterati, ma ha altresì ben poco
della convenzionalità rilevata in altre aree e forse eccessivamente
generalizzata. La esemplificazione di tutto ciò si ricava meglio dal vivo del
rilevamento; ma è riscontrabile anche in
vitro nei testi di questa raccolta, che Cassieri ha tradotti in prosa
popolare d'arte con sapiente e cosciente fedeltà.
Lungo
l'asse del confronto verticale si possono cogliere nella stessa area meridionale
differenze notevoli non formali che riguardano la qualifica dei personaggi e la
resistenza o mutazione dell'elemento magico.
Ai
fini dell'analisi morfologica di tipo proppiano contano, è vero, le azioni, non
i personaggi. Ma i personaggi hanno rilievo ai fini di un'analisi sociologica e
congiuntamente di una storicizzazione dei testi in fasi di creazione e
fruizione. La fitta presenza di re e principi come attori di azioni magiche
buone e cattive nelle novelle di Basile (come già in quelle di Masuccio
Salernitano) per un verso è coerente con la tradizione medievale dei maghi e
taumaturghi, per altro verso è riferibile alla specifica situazione politica
del Regno di Napoli tra quattro e cinquecento e rispecchia le luci e le ombre
della monarchia aragonese al suo tramonto e in un momento di forte scollatura
fra popolo, intellettuali e potere regio e baronale. Il compito e l'intento del
letterato cortigiano illinc et tunc era quello di adulare e colpire i potenti attraverso
la finzione favolistica. Re e principi, regine e principesse compaiono sì
ancora in gran numero nelle fiabe meridionali di tradizione orale, ma per lo più
non nel ruolo di protagonisti, il cui posto è preso o ripreso o continua a
essere occupato da contadini, pastori e pescatori, eroi del paradigma narrativo
evangelico in cui si identificano i personaggi reali, da sempre i più
rappresentativi, del mondo popolare. Ma
quel che può essere un carattere comune di distinzione fra novellistica
letteraria e popolare diventa, nell'ambito storico e geografico specifico del
Regno di Napoli nei secoli XV e XVI, un riflesso assai significativo della
distanza e separatezza dalla sovranità e dalla capitale del Regno, in cui sono
state tenute le popolazioni delle province continentali. Una controprova ne è
la affinità ben maggiore, sempre però dal punto di vista contenutistico, che
mostrano, nei riguardi delle novelle del Pentamerone,
i racconti popolari siciliani anche per il mantenimento di protagonisti di
abito regale: il che è, almeno in parte, attribuibile al ruolo di altra
capitale avuto da Palermo, oltre che - s'intende - alla tradizione narrativa
fiorita in Sicilia simultaneamente a livello aulico e popolare.
La
diversa qualifica dei personaggi è insieme di ordine culturale e sociale. Esso
incide sullo svolgimento del racconto. Il pesce miracoloso viene pescato da un
povero pescatore nella versione pugliese, come pure in alcune versioni
siciliane, ma da un re in due versioni siciliane, che peraltro riportano motivi
comuni al Pentamerone e assenti nelle
altre. I due fratelli sono figli di un povero pescatore nella versione pugliese,
mentre sono figli di un ricco mercante nel Pentamerone (I/vii
e ix): le rispettive narrazioni ritraggono segni e
comportamenti conformi a umili pescatori e a ben avviati mercanti.
Nelle
fiabe pugliesi l'ambiente contadino è generalmente rappresentato dalla figura
dello zappatore: vedi in questa raccolta i racconti intitolati Chi
fa e chi non fa, L'insano desiderio, Una ragazza giudiziosa, Le cento facce e
altri. Ma neppure questo è singolare della novellistica pugliese: ritroviamo
con pari frequenza lo stesso personaggio-protagonista nelle fiabe abruzzesi,
lucane e calabresi. Altresì comune alle regioni contermini, che integrano la
periferia del Regno di Napoli, è il processo di cristianizzazione dei
personaggi risolutori o adiutori e della stessa arma offensiva e difensiva del
magico che essi usano: santi, protettori e madonne salvatrici hanno il ruolo che
svolgono maghi e streghe di professione nella favolistica nordica, re e principi
dotati di poteri magici nella favolistica letteraria dei narratori di corte.
L'andamento del racconto, che nella rilevazione orale si misura soprattutto sul
tono della narrazione, tende all'apologo: il racconto, di qualsiasi specie esso
sia, è ora per lo più un fatto che vive solo nella memoria del narratore e
viene ripetuto per rappresentare il passato, quando la narrazione, pubblica o
privata, aveva una funzione pratica nel sistema di vita comunitaria.
A
questo punto, se si vogliono storicizzare tali caratterizzazioni, che ineriscono
anche ma non solo alle fiabe pugliesi, dobbiamo volgerci dal confronto
diacronico sull'asse verticale dei diversi livelli di formalizzazione ed
elaborazione dei testi narrativi nell'area meridionale al confronto sincronico
interregionale per registrare la cospicua consistenza delle somiglianze e
identità di forma e contenuto del singoli testi della Puglia, dell'Abruzzo,
della Basificata, della Calabria e della Sicilia.
Su
questo piano di confronto orizzontale è maggiore il rischio di una
delimitazione e caratterizzazione forzata di temi, motivi e forme, se non
vengano individuate le relative matrici storiche nell'ambito di una meridionalità
che è per tanta parte europea e per tanta parte mediterranea. Le due matrici si
sovrappongono, le due correnti s'intrecciano e s'influenzano reciprocamente, sì
che è difficile distinguerle. Comunque, le non poche affinità che si possono
constatare con un'analisi particolareggiata fra le versioni pugliesi e le
versioni neogreche di racconti circolanti in Europa si devono alla comune
cultura mediterranea. E non è un caso che tali affinità coincidano per lo più
con quelle già notate fra versioni siciliane e versioni neogreche. Così è, ad
esempio, per il racconto qui intitolato L'insano
desiderio, vicino al testo greco di Hahn (1864, n. 27) e alla siciliana (catanese)
Pelle di gatto (Aa.
Th.
510 B; cfr. Lo Nigro, p. 87).
Altre
fiabe di magia e in particolare le favole di animali, non rappresentate in
questa raccolta (come L'uomo e il serpente
di Castrignano [Morosi, pp. 75-761) danno ulteriori prove di una vicinanza
non fortuita, dovuta a fattori di ordine geografico, storico e culturale, fra i
testi pugliesi e il repertorio favolistico neogreco di antica tradizione
greco-orientale.
All'interno
della duplice orbita europea e mediterranea certe corrispondenze tematiche e
formali dei prodotti di narrativa popolare sono attribuibili a fatti storici non
fissabili in periodi cronologici determinati, in quanto dovuti a processi di
lunga durata e di ordine culturale, sociale ed economico, che hanno tenuto sia
pur relativamente collegate le regioni dell'Italia meridionale.
Penso,
in particolare, alla corrente letteraria e linguistica che accomuna tanta
produzione siciliana, calabrese e salentina: in questa corrente s'inserisce una
canzone narrativa di probabile origine calabrese che ha in Puglia versioni
poetiche molto belle, con l'avvio nell'antica forma metrica siciliana del doppio
settenario sdrucciolo e piano, e prossime alle calabresi, e ha anche una
versione in prosa intitolata U calabrese
ingannatore (La Sorsa 1927, p. 281). Questa
canzone sviluppa un motivo novellistico diffusissimo (Aa.
Th. B. 291 e tipo 311*),
qual è quello della sostituzione della sposa, la sorella minore e più bella
con la maggiore e più brutta (cfr. Thompson
[1946] 1967, p. 173, che nell'Italia meridionale riflette usi e pregiudizi
legati all'ordinamento patriarcale della famiglia.
Per
la Capitanata penso al continuo scambio, cui ho già accennato, di lingua e
prodotti orali che si è avuto tra la Puglia e l'Abruzzo con le migrazioni della
transumanza pastorale. Anche i pellegrinaggi hanno certamente avuto una grande
influenza per tale movimento e conformazione della novellistica orale.
Attraverso i pellegrinaggi devono essere circolati specialmente i
racconti di argomento religioso sulla Vergine e sui Santi, come La
bontà di Sant'Antonio (p. 164), La
Vergine strappa due anime al diavolo (p. 166), Gli scherzi del Signore (p. 168), San Pietro brontolone (p. 173) e altri simili, che pur si rifanno a
tipi e motivi internazionali, ma che sono scarsamente attestati nei repertori
italiani, forse perché appartengono a un'aneddotica religiosa di carattere
scherzoso trascurata dai classificatori della novellistica popolare delle
regioni italiane. Mi limito a rilevare la corrispondenza tra Gli
scherzi del Signore di questa raccolta (corrispondenti al tipo 774 di Aa.
Th.) e il n. *828/14c dell'indice siciliano del Lo Nigro; mentre il San
Pietro brontolone pugliese dei tipi 750 A e 759 di Aa.
Th. trova, qualche riscontro nella novellistica calabrese e lucana, dove
la diversità tra galantuomini e cafoni è motivo di un contrasto fra San Pietro
e Gesù nel momento di plasmare il cafone: San Pietro lo voleva con un sol
occhio, in modo che lo si potesse conoscere da lontano ed evitare d'incontrarlo,
Gesù era invece contrario, sostenendo che il cafone può anche diventare
galantuomo (cfr. Pasquarelli, Folklore calabrese, IV, 1918, pp. 7-12). Non mancano, del resto, in alcuni di questi racconti
religiosi riferimenti specifici a pellegrinaggi, che proprio per la loro
irrilevanza ai fini dello svolgimento della trama del racconto sono spie della
localizzazione di quei racconti. È
il caso del riferimento al pellegrinaggio a San Michele sul Gargano nell'Orco
e le galline (p. 133), che appartiene
al tipo 883 A dell'Aa. Th., ma che
non ha corrispondenze nei tre indici novellistici regionali italiani, se si
eccettua il n. 709 q del D'Aronco, in cui, però, non compare il protagonista
della fiaba pugliese, che è l'orco.
I
rapporti commerciali che la Puglia ha avuto con l'Oriente e con Venezia in età
medievale e moderna hanno lasciato qualche traccia anche nella letteratura
narrativa dei marinai pugliesi. Un vecchio marinaio di Molfetta, cieco di un
occhio e analfabeta, riferì al La Sorsa, fra il 1930 e il '36, la canzone di
Bellafronte in dialetto molfettese, che qui compare tradotta col titolo Affari
di cuore (p. 122). Le vicende narrate in questa canzone ruotano intorno al
motivo del 'morto riconoscente', che è uno dei più fecondi della novellistica
d'arte e popolare (Aa. Th. 505-508;
BoltePolivka III, pp. 490 sgg.), come fece notare Vidossi (1936).
Il testo dialettale pugliese in versi sembra accostarsi a un poemetto
popolare del sec. XVIII, che fu divulgato da varie stampe dell'Ottocento. Si
tratta della Istoria bellissima di
Stellante Costantina figliuola del Gran Turco, la quale fu rubata da certi
cristiani che teneva in corte suo padre e tu venduta a un mercante di Vicenza
presso Salerno, composta da Giovanni Orazio Brunetto. Ma alcune notevoli
divergenze e soprattutto la forma metrica della canzone molfettese, che non ha
nulla delle ottave del poemetto del Brunetto ed è forgiata sullo schema dei
canti narrativi dell'Italia centromeridionale in endecasillabi raggruppati forse
in distici o forse in lasse, lascia supporre l'influenza di altre fonti più
antiche di tradizione orale.
I
Origine
medievale, non tanto per il personaggio a cui l'episodio leggendario viene
riferito quanto per il suo innestarsi su un tema favolistico classico, si può a
maggior ragione riconoscere a Gli
intoccabili (p. 120). Questo
racconto ricalca, come quello analogo raccolto una sessantina d'anni fa tra i
contadini di Avigliano (Basilicata), il mito ovidiano (di origine macedone
secondo Erodoto) del re Mida (Aa.
Th.
F. 511. 2. 2; cfr. Thompson [1946]
1967, p. 372). Questi
punì con la morte il barbiere che aveva svelato alla terra il segreto delle
orecchie d'asino del suo sovrano. La leggenda è stata riplasmata nella forma
moderna in Croazia intorno alla figura dell'imperatore Diocleziano, crudele
persecutore dei cristiani, e si è diffusa in Europa adattandosi a vari
personaggi storici. È uno dei tipi novellistici in cui il protagonista, se è
irrilevante per la struttura del racconto, rappresenta un referente storico
variabile,a seconda dei luoghi. La scelta del personaggio risponde a un legame
reale che esso ha avuto o si ritiene abbia avuto col territorio. Tale legame è
sempre segnato da una costruzione di grande spicco: per il suddetto racconto in
Croazia è il maestoso palazzo presso Spalato, che Diocleziano si fece costruire
a Salona, dove trascorse gli ultimi anni della sua vita; in Puglia e Basilicata
sono i magnifici castelli federiciani di Castel del Monte e Lagopesole, che la
tradizione popolare attribuisce a dimore di Federico Barbarossa, prima e oltre
che di Federico II. Un'analoga formazione archeologica, cioè legata a imponenti
costruzioni venute alla luce dagli scavi archeologici, hanno le leggende
virginiane pugliesi sorte nei luoghi che si ritiene o s'immagina siano stati
visitati da Virgilio: il quale, di fatto, soggiornò a Brindisi e vi morì nel
19 a.C. Ma nei racconti di tale categoria il dato storico viene sommerso durante
la sua lievitazione leggendaria, che rende magici il personaggio e le sue
azioni, onde spesso il tipo di narrazione diventa disponibile a personaggi
diversi e di diverse epoche. Anche in questo genere la storicità e località
dei relativi racconti è di adozione.
La
diffusione internazionale della maggioranza dei tipi dei racconti popolari
pugliesi lascia, dunque, un minimo spazio alla individuazione di oicotipi
pugliesi. Ciò vale anche per le altre regioni, per cui è estremamente
rischioso e forzato estrarne elementi connotativi di una cultura e società
regionale dimenticando la ripetibilità di questi elementi al di là e al di
sopra di tempi e luoghi determinati, e non tenendo conto, pur in una stessa
area, della non simultaneità dei processi culturali e sociali. Si possono
soltanto indicare alcuni temi e motivi narrativi che si sono innestati con
maggiore fecondità nella cultura popolare pugliese, partecipe allo stesso grado
della cultura occidentale europea, latina e germanica, e della cultura orientale
greco-mediterranea.
La
fortuna, che è tra i motivi più presenti nella novellistica popolare pugliese,
è concepita sia come fato imperscrutabile, proprio del mondo greco-mediterraneo,
sia alla maniera medievale come entità cieca o bendata che con la sua ruota
rende o toglie ricchezze. Vi ritroviamo il motivo specifico del tesoro nascosto
rinnovato dal contadino mentre zappa (vedi nel racconto Il Pan d'oro di
questa raccolta: p. 80), il cui archetipo medievale letterario ci è dato da
Dante (Conv.
IV
e D.C. If. VII, XV, Pd. XVI).
Di stampo medievale è anche la contesa tra la Ricchezza e la Morte, di
cui a far le spese è il contadino Cola (in La
scelta crudele, p. 84). E c'è
pure lo scontro fra La Miseria e la Morte (nell'ultimo
racconto qui tradotto), che, pur inserendosi nel circuito europeo occidentale -
popolare e letterario (soprattutto in Francia [Aa. Th. 330 A]) - di questo tema, riceve fra i poveri del sud una
speciale connotazione economico-sociale, dichiarata nel finale, allorché la
perfida Morte, prigioniera sull'albero, una volta concluso il patto con la
maliziosa Miseria, «scese dall'albero nera di vendetta e cominciò a seminare
terremoti, pestilenze, colera e altri terribili castighi di Dio che
distruggevano l'umanità. Uno dopo l'altro scomparvero popoli e paesi, sudditi e
sovrani, tranne la Miseria, che [... ] esiste tuttora e chissà per quanto
esisterà sulla faccia della terra». Aiutanti magici per eccellenza sono i
folletti in tutta la favolistica europea, mediterranea e nordica (le fiabe
irlandesi raccolte e raccontate da W.B. Yeats ce ne danno una casistica
foltissirna). Li ritroviamo
massimamente attivi nei racconti salentini (Le
palle d'oro, Il folletto aggiustatutto, Lo Scazzamurello innamorato, Altre
storie dello Scazzamurello),
in corrispondenza con la credenza, radicatissima nel Salento, ma diffusa anche
nella Puglia settentrionale e centrale, della esistenza e dell'azione invisibile
di questi piccoli esseri diabolici, che fanno favori e dispetti a non finire.
Dal loro aiuto dipende soprattutto il ritrovamento di tesori nascosti:
per tale funzione il folletto salentino mostra di essere l'erede diretto dell'incubus
operante nel mondo classico, come testimonia, fra gli altri, Petronio nella Cena Trimalchionis. È altresì
interessante osservare il potere metamorfico del folletto, per cui, ad esempio,
nel racconto Le palle d'oro (p. 99) il
folletto compare e agisce in forma di serpentello. Nelle credenze magico-religiose delle culture agrarie il
serpente reincarna lo spirito degli avi, per cui nella favolistica può figurare
come padre (cfr. Propp 1972, p.
439) e a questa credenza si riferisce la bella otrantina Maria, nel suddetto
racconto, allorché così si rivolge al folletto-serpentello che le appare
d'improvviso in mezzo alla stanza: «'Uh!' disse 'chi sei tu, l'anima della mia
mamma o quella di mio padre?'».
Dell'età
moderna si è riflessa nei racconti popolari l'idea del brigantaggio come storia
contadina. Da qui la figura del brigante-galantuomo nel racconto così
intitolato in questa raccolta (p. 68), mentre nelle versioni siciliane del tipo
950 dell'Aarne-Thompson, a cui appartiene il nostro racconto, il ladro del
tesoro del re, che viene alla fine riabilitato e premiato per la sua abilità
dallo stesso sovrano, è un muratore.
L'ondata
veristica e l'ideologia sottesa al recupero in re o in proprio della
narrativa popolare orale, nella particolare duplice forma che si ebbe in
Sicilia, alimentarono la formazione o lo sviluppo di racconti che si attengono
alla filosofia popolare delle 'parità morali' esposta e documentata dal
Guastella (1884), in quanto rivendicano una uguaglianza umana contro la
disuguaglianza economica e sociale stabilita dal destino della nascita, cui si
contrappone talvolta la mobile, benefica o malefica, fortuna. V'è qualche fiaba
che si svolge proprio a dimostrazione di una verità proverbiale. Così nel
citato racconto presente in questa raccolta col titolo
Chi fa e chi non fa si prova che «la fortuna fa i soldi» e non il
contrario come è abituato a credere il contadino: la storia s'inizia e si
chiude con questa massima.
Vi
sono poi istituti della società contadina che trovano il loro riconoscimento
nei racconti popolari. I riferimenti più numerosi riguardano il comparatico e
il vicinato. Versioni dei tipi 332 e 425 dell'Aarne-Thompson, registrate di
recente a Collepasso nel Salento, confermano la considerazione dei compari di
battesimo e di cresima, che vengono scelti tra persone o della stessa classe
sociale o di classi superiori: medico, avvocato o prete; quest'ultimo è
chiamato 'signore compare' dal contadino in racconti salentini dei tipi 708 e
841. Altri racconti sottolineano l'importanza del vicinato. Il legame tra i
vicini viene codificato in regole di vita comune: la vicina accudisce spesso per
molte ore della giornata il bambino che le viene affidato dalla madre che va a
lavorare in campagna. Il vincolo di vicinato fa sì che le due comari si
ameranno come suredde; ma non è raro
il caso che ne scaturiscano tensioni, ostilità, inimicizie, perché dice il
proverbio: quantu kiù kiove kiù mprima
scampa, con duplice (ambivalente) allusione all'improvviso sorgere e alla
rapida soluzione della lite.
Naturalmente
una più libera e più diretta riflessione di usi e credenze nella narrativa
popolare si ha negli aneddoti e nei racconti locali, non classificati negli
indici di tipi e motivi di Aarne-Thompson. Tuttavia le corrispondenze facilmente
rintracciabili sono difficilmente circoscrivibili; anche per la formazione di
aneddoti e racconti locali esistono schemi fissi che si riempiono di ingredienti
e motivi esistenziali comuni a tutta un'area storica pluriregionale.
Né
sono connotativi di pugliesità dei racconti e neppure delle loro varianti i
riferimenti a paesi e fatti locali (il re di Vieste, burrate di Andria, alle
porte di Taranto, alla locanda di Taranto, briganti di Bovino, mezzadri e
massari di Canosa e Molfetta, Monte S. Angelo, calzolaio di Terlizzi, S.
Cesareo, santuario dell'Incoronata ecc.). Si tratta di dati sovrapposti, nella
fase di composizione o in quella di esecuzione del racconto, e servono ad
aumentarne la credibilità, o meglio a trasmettere al pubblico o all'ascoltatore
singolo la convinzione del narratore che si tratta di 'storia vera': con questa
denominazione il narratore distingue un fatto realmente accaduto dai fatti
fantastici, denominati semplicemente 'storie'.
Stereotipato
secondo moduli di larga diffusione italiana ed europea è il formulario d'inizio
e di chiusura, che il lettore, pugliese o non pugliese, troverà familiare. Vana
è, dunque, la ricerca di una pugliesità di contenuto e di forma nei testi che
la scrittura (e la stampa) del raccoglitore ha resi anonimi (la citazione del
solo nome di chi ha narrato per lo più occasionalmente il racconto ha valore
pressoché nullo), mentre un tempo erano sì collettivi ma segnati da una
personale e rinnovata oralità del narratore. È possibile, invece, cogliere la
individualità del narrare (sia pure solo nella fase di registrazione che sempre
la condiziona) negli ultimi narratori viventi, la cui personalità e pugliesità
(in senso anagrafico, sociale e culturale) si trasmette ai racconti, noti o non
noti, che essi narrano.
Uno
di essi è Alfredo Paglialunga di Collepasso.
Ha raccontato ventinove racconti a un mio allievo (Mellone 1979-80), il
quale ha notato come egli inseriva spesso nel racconto considerazioni personali
sulla diversità dei tempi attuali rispetto al passato, dicendo, per esempio,
dei giovani che si troveranno male perché non ascoltano i vecchi, e così,
infatti, concludeva il racconto I vecchi
sono saggi (Aa. Th. *981), già
rilevato dal La Sorsa (1927, pp. 196-199, senza questa chiusa) e da DiS (1975,
p. 247): Li vekki se tenene pe' cunzij, ma moj, li giovani te moi nu mbolene li
vekki pe' cunzij, comu olene fazzane, fazzane, na quiddu è sciutu
e s'à manatu intra la cisterna (Mellone 1979-80, p. 43. (Si riferiva al
suicidio di un diciassettenne di Collepasso avvenuto proprio lo stesso giorno in
cui fu registrato il testo.)
Ma
vediamo da vicino come è vissuto e che cosa narra e come narra il contastorie
di Collepasso: Alfredo Paglialunga è nato il 21-2-1925. È analfabeta. Con
orgoglio afferma di essere nato nell'anno santo (addu
utu la furtuna cu nascu propriu all'annu santu); ma aggiunge che per ironia
della sorte è nato cieco e fu abbandonato dai suoi genitori all'età di un
anno. Da allora è passato da un istituto di beneficenza all'altro. Fino a venti
anni fa viveva in un ospizio per vecchi. Ora
vive da solo in una casa presa in affitto: un monovano di circa 4 mq., arredato
di pochi mobili (un lettino con sopra un cappotto per coperta, un armadietto, un
tavolino), di una cucina a gas e di un televisore; c'è anche un'angoliera piena
di fotografie con una lampada piccolissima.
Il nostro allievo rilevatore notò sul contatore della luce elettrica
accanto alla porta d'ingresso un pezzo di pane bianco, che (lo spiegò lo stesso
Paglialunga) è 'pane santo', cioè pane benedetto dal sacerdote il giovedì
santo durante la rievocazione dell'ultima cena, ed egli lo tiene sempre lì,
rinnovandolo annualmente, perché «ha molte felici funzioni», come quella di
proteggere la casa da jettature, impedire l'ingresso a spiriti maligni e
specialmente di scongiurare temporali: quando il cielo è nuvoloso basta gettare
per strada una mollica di quel pane e il temporale si allontana, come
testimoniano i vecchi, ai quali, dice Paglialunga, come un padron 'Ntoni senza
famiglia, bisogna credere. Dal 1968
lavora come servitureddu in un negozio
di generi alimentari, di proprietà di una zitella, sua coetanea, Maria C., che
egli menziona molte volte nei suoi racconti; non riceve retribuzione in denaro,
ma (come egli stesso dice) se nu bbene
pahatu a lana vene pahatu a linu, viene cioè compensato in generi
alimentari: pasta, pane e olio. Paglialunga
i racconti che narra li ha imparati negli ospizi. Un tempo ne conosceva nu
bastimentu, ne ha raccontati ventinove, fra aneddoti, storie vere e
fantastiche. Tema predominante è la fame, una fame atavica a cui i nati poveri
tentano invano di sfuggire.il Cristo, che Paglialunga nel racconto della Morte dice ingiusto, a decidere chi deve essere ricco e chi povero;
è il Cristo, chegli chiama anche Fortuna, a organizzare la vita degli uomini.
Questo Cristo-destino, al quale ci si affida con un fatalistico fazza Diu,
ribadisce il suo potere discriminatorio nella versione salentina (di Paglialunga)
del racconto sui due compari (tipo 841 Aa.
Th.), rinfacciando al compare ricco di aver causato la morte del compare
povero per avergli regalato un pane pieno di monete: «povero l'ho fatto, ricco
lo vulisti, resuscitalo tu se puoi»; da confrontare con l'analoga ma meno viva
chiusa della versione di Manfredonia, che qui si riporta (La Sorsa 1927, pp.
149-151), in cui del messaggio di Cristo si fa intermediario per beffa lo zio
canonico. Questi era stato
beneficiato dal buon ciabattino con la prima pizza d'oro del sovrano e alla fine
è proprio lui che accusa il sovrano della morte del ciabattino per non aver
rispettato il volere di Dio: « Se Dio lo avesse voluto ricco non lo avrebbe
fatto nascere povero. Tu invece sei
andato oltre: per farlo ricco gli hai procurato la morte ». Partecipata è la
narrazione di Paglialunga, con riferimenti alla sua vita e al suo stato di cecità
e povertà; parlando di un personaggio cieco dice: allora
c'era unu alli condizioni mei [... ]
li benefattori lu cazzane e lu vestine comu a mio lu stessu; oppure: tenìa na luce comu la tegnu jeu culla bona salute.
Quella
di Paglialunga è una figura emblematica di contastorie pugliese-salentino, che
porta riflesso nella sua esistenza fisica e attività reale il modello mitico di
tradizione greco-mediterranea del cantore epico cieco e vagabondo.
Giova soffermarsi su di lui, anche se nella presente raccolta abbiamo
riportato solo uno dei ventinove racconti da lui raccontati, perché il suo modo
di narrare storie vere o fantastiche ci offre altri elementi consistenti per una
caratterizzazione, non distintiva (che non può esserci) ma socialmente e
culturalmente significativa, in un quadro extraregionale, della narrativa
popolare pugliese. Chimerica è la
pugliesità dei racconti, effettiva è solo quella dei narratori. Le storie vere
costituiscono una parte cospicua dei racconti di Paglialunga, in cui perciò si
riversano fatti e nomi reali della comunità di Collepasso: Ginu il sacrestano, Mesciu
‘Ntunuccia il barbiere, e così altri.
Anche
il linguaggio verbale e gestuale risponde a un codice mitico-rituale riprendendo
dal vivo comportamenti e aspetti della cultura contadina meridionale.
Un esempio. Riferendosi a un
matrimonio egli dice: se spusara a 'ngrazia
te Diu, cu canti, soni, divertimenti, balli e kiakkerate. Dove nulla è superfluo per la rappresentazione di un
matrimonio contadino, la cui rumorosità rispetto al matrimonio borghese è un
compenso psicologico e sociale alla indigenza del vivere quotidiano, come hanno
ben avvertito narratori e poeti colti del mondo popolai-e, fra i quali Albino
Pierro in alcuni versi dialettali lucani che traduco: «dovreste vedere quello
che fanno i Rabatanesi quando c'è uno sposalizio; vi otturereste le orecchie
per non sentire chitarre mandolini e mortaretti, strida di ragazzi e
d'organetti, e batterie (di mortaretti) e tuoni di tamburo ».
Del
codice fiabesco sono presenti nella narrazione di Paglialunga le formule
d'inizio, come la classica del c'era na fiata, e di fine, come e
spicciau oppure stèsera felici e contenti, con l'aggiunta interessantissima
che riproduce la sequenza distributiva dei circoli aristocratici di narratori e
narratrici che costituivano situazioni reali ritratte nella cosiddetta cornice
delle cento o cinquanta famose giornate narrative: cuntatime n'addu ui ca nu nde sacciu kiui. Formule come queste hanno ancora un valore connotativo
del modo di narrare nel Salento se ascoltate dalla voce di un narratore
semiprofessionista come Paglialunga; lo trasmettono, invece, smorzato nei testi
impersonali che leggiamo nelle raccolte a stampa. Tra i modi meno comuni di esprimere il vivere felici e
contenti rileviamo in questa raccolta quello della Donna
di fiore (p. 148): «contenti e contentoni / la testa loro nel pentolone»;
o quello di Nerino (p. 154): «Io con
un piatto di pesce fritto / e a voi lasciai questo scritto». E c'è pure
qualche eco limpidissima di stile aedico della tradizione epica canterina: «Ma
intanto che questi regnanti perdono tempo a salutarsi nell'androne, noi facciamo
un passo indietro e torniamo alla vera Maria rimasta nuda dietro lo scoglio» (Le
palle d'oro, p. 99).
Il
fatto è che dei testi impersonalmente riprodotti dai raccoglitori - e sono la
maggioranza di quelli tradotti nella presente raccolta - ci è impossibile
risalire al narratore o alla narratrice; e anche quando vi riuscissimo ci
sfuggirebbe il momento del narrare nella reciprocità del rapporto
narratore-pubblico, che potrebbe rivelarci almeno parzialmente il contesto,
essenziale per la significazione del testo. Scomparsa la funzione sociale, è
rimasta in qualche narratore l'aspirazione a una funzione estetica, che si
manifesta anche nella narrazione privata ch'egli fa al solo raccoglitore, al
quale, per esempio, Paglialunga chiedeva, alla fine di ogni registrazione, se i
suoi racconti fossero più belli di quelli degli altri narratori. Da recenti
ricerche sul campo risulta che il saper raccontare storie non è sempre un
titolo di merito, ché anzi spesso è oggetto di maldicenza, per l'evolversi
stesso del codice sociale, specie quando i racconti svelano comportamenti e
fatti reali della comunità. È il caso di una narratrice salentina, chiamata
Tota, settantacinquenne analfabeta, che da giovane conosceva, a suo dire,
moltissimi racconti; pochi ora ne ricorda di quelli che apprese quando andava a
lavorare in tabacchificio e che raccontava ai suoi, figli e ai bambini del
vicinato; ma sono proprio i vicini ora a reputarla intrigante chiamandola 'la
segretaria', per cui non vuole che essi sappiano che quei racconti li narra ad
estranei ed è stata accorta nell'usare nomi fittizi al posto di quelli di
persone del paese, che sono i personaggi delle sue storie.
La
frantumazione dei nuclei, luoghi e momenti aggregativi della società contadina
meridionale ha determinato altresì la perdita di altre funzioni, un tempo
preminenti, del narrare, come la funzione dilettevole e la didascalica, che
nella effettiva realtà erano combinate e non separate come vuole la distinzione
romantico-grimmiana di fiabe e leggende. L'arte attiva del narrare è una delle
espressioni della oralità creativa tradizionale maggiormente coinvolte nel
processo di trasformazione della società.
Il demo-antropologo non può che fare storia di un'arte sommersa,
individuando (fin dove gli è possibile) le caratteristiche testuali e
contestuali della fase attiva e di quella che tale non è più.
Giovanni Battista Bronzini |